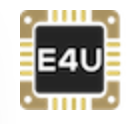Cos'è un Oscilloscopio a Raggi Catodici?
Un Oscilloscopio a Raggi Catodici (CRO) è uno strumento generalmente utilizzato in laboratorio per visualizzare, misurare e analizzare varie forme d'onda di circuiti elettrici. Un oscilloscopio a raggi catodici è un tracciante X-Y molto veloce che può visualizzare un segnale di ingresso rispetto al tempo o a un altro segnale.
Gli oscilloscopi a raggi catodici utilizzano punti luminosi prodotti dal colpire il fascio di elettroni e questo punto luminoso si muove in risposta alle variazioni della quantità di ingresso. In questo momento potrebbe sorgere una domanda nella nostra mente: perché usiamo solo un fascio di elettroni? La ragione dietro ciò è l'effetto ridotto del fascio di elettroni che può essere utilizzato per seguire le variazioni dei valori istantanei di una quantità di ingresso rapidamente variabile. Le forme generali degli oscilloscopi a raggi catodici funzionano con tensioni.
Quindi la quantità di ingresso di cui abbiamo parlato sopra è la tensione. Oggi, grazie ai trasduttori, è possibile convertire varie quantità fisiche come corrente, pressione, accelerazione ecc. in tensione, consentendoci così di avere rappresentazioni visive di queste varie quantità su un oscilloscopio a raggi catodici. Ora vediamo i dettagli costruttivi dell'oscilloscopio a raggi catodici.
Costruzione dell'Oscilloscopio a Raggi Catodici
La parte principale dell'oscilloscopio a raggi catodici è il tubo a raggi catodici, noto anche come cuore dell'oscilloscopio a raggi catodici.

Discutiamo ora la costruzione del tubo a raggi catodici per comprendere la costruzione dell'oscilloscopio a raggi catodici. Fondamentalmente, il tubo a raggi catodici è composto da cinque parti principali:
Pistola elettronica
Sistema di piastre di deviazione
Schermo fluorescente
Involucro di vetro
Base
Avrai bisogno di tutti e 5 questi componenti per costruire il tuo oscilloscopio DIY. Ora discuteremo questi 5 componenti in dettaglio:
Pistola Elettronica:
È la sorgente del fascio di elettroni accelerati, energizzati e focalizzati. È composta da sei parti, ovvero riscaldatore, cattedra, griglia, anodo preacceleratore, anodo di focalizzazione e anodo acceleratore. Per ottenere un'elevata emissione di elettroni, lo strato di ossido di bario (che è depositato sulla fine della cattedra) viene riscaldato indirettamente a temperatura moderata. Gli elettroni passano poi attraverso un piccolo foro chiamato griglia di controllo, fatto di nichel. Come suggerisce il nome, la griglia di controllo, con la sua polarità negativa, controlla il numero di elettroni o, indirettamente, l'intensità degli elettroni emessi dalla cattedra. Dopo aver passato la griglia di controllo, questi elettroni vengono accelerati con l'aiuto degli anodi preacceleratore e acceleratore. Gli anodi preacceleratore e acceleratore sono collegati a una tensione positiva comune di 1500 volt.
Ora, dopo questo, la funzione dell'anodo di focalizzazione è quella di focalizzare il fascio di elettroni prodotto. L'anodo di focalizzazione è collegato a una tensione regolabile di 500 volt. Ora esistono due metodi per focalizzare il fascio di elettroni, ed eccoli elencati di seguito:
Focalizzazione elettrostatica.
Focalizzazione elettromagnetica.
Qui discuteremo in dettaglio il metodo di focalizzazione elettrostatica.
Focalizzazione Elettrostatica
Sappiamo che la forza su un elettrone è data da – qE, dove q è la carica sull'elettrone (q = 1,6 × 10-19 C), E è l'intensità del campo elettrico e il segno negativo indica che la direzione della forza è opposta a quella del campo elettrico. Ora utilizzeremo questa forza per deflettere il fascio di elettroni proveniente dalla pistola elettronica. Consideriamo due casi:
Caso Uno
In questo caso abbiamo due piastre A e B come mostrato nella figura.

La piastra A è a potenziale +E mentre la piastra B è a potenziale –E. La direzione del campo elettrico va dalla piastra A alla piastra B ad angolo retto rispetto alle superfici delle piastre. Le superfici equipotenziali sono anche mostrate nel diagramma, perpendicolari alla direzione del campo elettrico. Mentre il fascio di elettroni passa attraverso questo sistema di piastre, si deflette nella direzione opposta al campo elettrico. L'angolo di deflessione può essere facilmente variato cambiando il potenziale delle piastre.
Caso Due
Qui abbiamo due cilindri concentrici con un potenziale differenziale applicato tra di essi, come mostrato nella figura.

La direzione risultante del campo elettrico e le superfici equipotenziali sono anche mostrati nella figura. Le superfici equipotenziali sono contrassegnate da linee tratteggiate, curve in forma. Ora qui siamo interessati a calcolare l'angolo di deflessione del fascio di elettroni quando passa attraverso questa superficie equipotenziale curva. Consideriamo la superficie equipotenziale curva S come mostrato di seguito. Il potenziale sul lato destro della superficie è +E mentre il potenziale sul lato sinistro della superficie –E. Quando un fascio di elettroni incide ad un angolo A rispetto alla normale, si deflette di un angolo B dopo aver passato la superficie S, come mostrato nella figura sottostante. La componente normale della velocità del fascio aumenterà poiché la forza agisce nella direzione normale alla superficie. Ciò significa che le velocità tangenziali rimarranno invariate, quindi, uguagliando le componenti tangenziali, abbiamo V1sin (A) = V2sin(B), dove V1 è la velocità iniziale degli elettroni, V2 è la velocità dopo aver passato la superficie. Ora abbiamo la relazione come sin(A)/sin(B)=V2 / V1.
Possiamo vedere dall'equazione precedente che c'è una curvatura del fascio di elettroni dopo aver passato la superficie equipotenziale. Quindi questo sistema è anche chiamato sistema di focalizzazione.
Deflessione Elettrostatica
Per trovare l'espressione per la deflessione, consideriamo un sistema come mostrato di seguito:


Nel sistema sopra abbiamo due piastre A e B che sono a potenziale +E e 0 rispettivamente. Queste piastre sono anche chiamate piastre di deflessione. Il campo prodotto da queste piastre è nella direzione dell'asse y positivo e non c'è forza lungo l'asse x. Dopo le piastre di deflessione abbiamo uno schermo attraverso il quale possiamo misurare la deflessione netta del fascio di elettroni. Ora consideriamo un fascio di elettroni che arriva lungo l'asse x, come mostrato nella figura. Il fascio si deflette di un angolo A, a causa della presenza del campo elettrico e la deflessione è nella direzione positiva dell'asse y, come mostrato nella figura. Ora deriviamo un'espressione per la deflessione di questo fascio. Per la conservazione dell'energia, abbiamo la perdita di energia potenziale quando l'elettrone si sposta dalla cattedra all'anodo acceleratore dovrebbe essere uguale al guadagno di energia cinetica dell'elettrone. Matematicamente possiamo scrivere,

Dove, e è la carica sull'elettrone,
E è il potenziale differenziale tra le due piastre,
m è la massa dell'elettrone,
e v è la velocità dell'elettrone.
Pertanto, eE è la perdita di energia potenziale e 1/2mv1/2 è il guadagno di energia cinetica.
Dall'equazione (1) abbiamo la velocità v = (2eE/m)1/2.
Ora abbiamo l'intensità del campo elettrico lungo l'asse y è E/d, pertanto la forza che agisce lungo l'asse y è data da F = eE/d dove d è la separazione tra le due piastre di deflessione.
A causa di questa forza l'elettrone si defletterà lungo l'asse y e sia la deflessione lungo l'asse y uguale a D, che è segnata sullo schermo come mostrato nella figura. A causa della forza F c'è un'accelerazione netta verso l'alto dell'elettrone lungo l'asse y positivo e questa accelerazione è data da Ee/(d × m). Poiché la velocità iniziale lungo la direzione y positiva è zero, quindi, dall'equazione del moto, possiamo scrivere l'espressione dello spostamento lungo l'asse y come,

Poiché la velocità lungo la direzione x è costante, quindi possiamo scrivere lo spostamento come,

Dove, u è la velocità dell'elettrone lungo l'asse x.
Dalle equazioni 2 e 3 abbiamo,

Che è l'equazione della traiettoria dell'elettrone. Ora, differenziando l'equazione 4, abbiamo la pendenza, cioè.

Dove, l è la lunghezza della piastra.
La deflessione sullo schermo può essere calcolata come,

La distanza L è mostrata nella figura sopra. L'espressione finale di D può essere scritta come,

Dall'espressione di deflessione, possiamo calcolare la sensibilità di deflessione come,